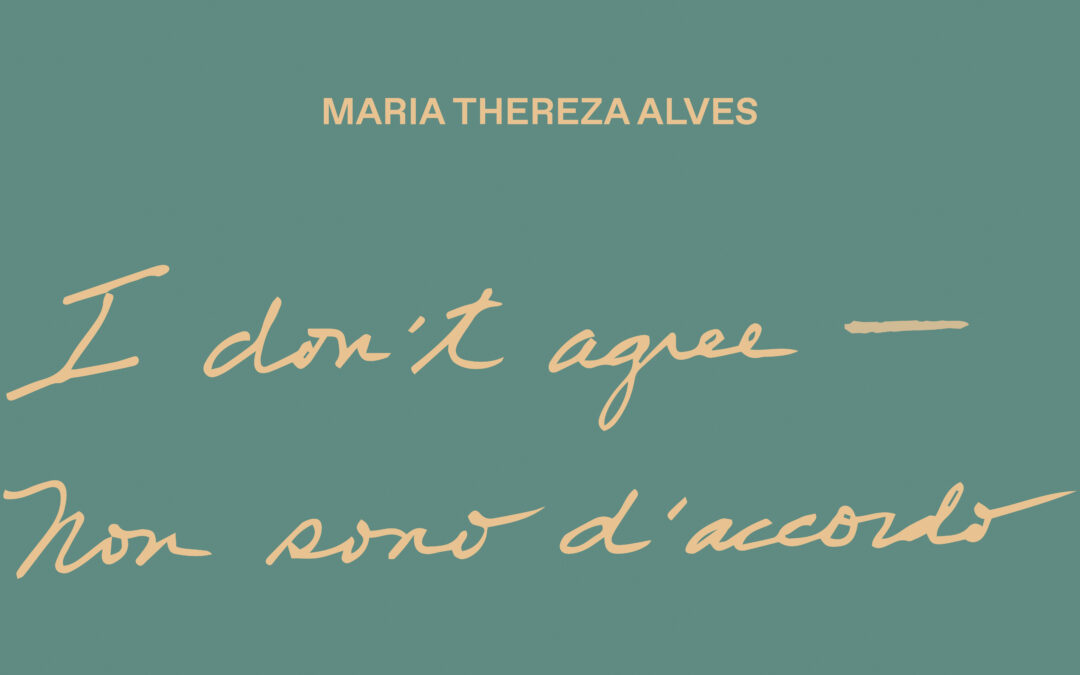Durante una delle prime visite di Alves al Museo delle Civiltà, dopo l’invito nella primavera del 2022 a far parte del nuovo gruppo degli artisti-ricercatori, rimase turbata nel constatare che in alcune delle vetrine delle Collezioni di Arti e Culture Americane fossero ancora esposte teste Shuar mummificate ed altri resti umani. L’artista concordò in quell’occasione con Loretta Paderni, Funzionaria antropologa responsabile delle collezioni, di farli ricoverare nelle camere climatiche dei depositi museali. Con quel gesto di rispetto nei confronti di quei resti, Alves volle collaborare con il Museo per interrompere l’ostensione di corpi sottratti dai loro sepolcri originali e sottoposti alla supposta neutralità scientifica di una vetrina museale, a migliaia di chilometri dal loro luogo di origine. I resti furono così progressivamente rimossi e da quel momento l’artista diede avvio ad un doppio dialogo: da un lato con i suoi contatti di lungo termine all’interno delle comunità indigene in Brasile – per metterli a conoscenza degli oggetti presenti al Museo – e dall’altro con le Funzionarie e i Funzionari del Museo per ripensare insieme nuovi possibili allestimenti che comprendessero le sollecitazioni ricevute dalle comunità indigene dai cui contesti provengono gli oggetti in collezione. Origina da queste visite e questi scambi l’intenzione di segnalare, in attesa dei riallestimenti che avverranno nel corso del 2024, ciò con cui l’artista sente di non essere d’accordo rispetto agli allestimenti attuali, perché di parte, risultato di pregiudizi pregressi o non informate rispetto alla realtà storica emersa negli ultimi decenni di studi.
Analizzando i testi a parete presenti nell’allestimento esistente (realizzato in tre fasi dal 2000 al 2008), si notano una serie di nozioni stereotipate che rivelano quanto, nelle informazioni fornite ai visitatori, sia sostanzialmente ancora assente la voce dei soggetti la cui cultura materiale e immateriale è esposta nel Museo, perpetrando quindi un racconto che è di fatto espressione di un’interpretazione museografica occidentale.
All’ingresso del percorso, ad esempio, campeggia la frase “1492: l’Europa scopre l’America” che ribadisce la convinzione che i territori americani siano stati scoperti dagli europei, negando la millenaria storia delle popolazioni indigene che già li abitavano. A questo proposito, nel libro Giungle. Come le foreste tropicali hanno dato forma al mondo e a noi, Patrick Robert, archeologo e ricercatore del Max Planck Institute di Monaco di Baviera, scrive: “Sempre più attivisti e istituzioni indigene stanno chiedendo che le occasioni celebrative verso Cristoforo Colombo siano sostituite da celebrazione delle società indigene pre-coloniali, riconoscendo che l’impatto che le azioni degli esploratori europei hanno avuto sulle culture, popolazioni e paesaggi tropicali, non sono affatto motivo di festeggiamenti”. Altri ricercatori in campo scientifico[1], che hanno studiato gli aspetti climatici di quel periodo storico, hanno affermato: “mentre l’Europa era nei primi giorni del suo Rinascimento, c’erano imperi nelle Americhe nei quali prosperavano più di 60 milioni di persone. Ma il primo contatto europeo nel 1492 portò malattie nelle Americhe che devastarono la popolazione nativa, e il conseguente crollo dell’agricoltura nelle Americhe fu così significativo che potrebbe aver persino raffreddato il clima globale”. Le più recenti ricerche, ci ricorda Robert, attestano infatti che il 90% delle popolazioni indigene delle aree tropicali fu spazzata via nei 150 anni successivi al 1492, a causa di ripetute ondate di malattie e stermini organizzati. Già nel 1552 nel testo Brevissima relazione della distruzione delle Indie Bartolomé de Las Casas – prete dominicano spagnolo che partecipò alla colonizzazione di Cuba – racconta: “Per quanto riguarda il vasto continente, che è dieci volte più grande di tutta la Spagna, compresi Aragona e Portogallo, che contiene più terra della distanza tra Siviglia e Gerusalemme, o più di duemila leghe, siamo sicuri che i nostri spagnoli, con i loro atti crudeli e abominevoli, hanno devastato la terra e sterminato il popolo razionale che lo abitava pienamente. Possiamo stimare con certezza e verità che nei quarant’anni trascorsi, con le azioni infernali dei cristiani, sono stati ingiustamente uccisi più di dodici milioni di uomini, donne e bambini. In verità, credo senza cercare di ingannare me stesso che il numero degli uccisi sia più di quindici milioni.” [2]
Sempre nella prima stanza del percorso si trova una mappa che riporta le molteplici scoperte e conquiste di Colombo e dei suoi epigoni, ma manca l’indicazione delle conseguenze di tali azioni, raccontate come se quei territori fossero una terra nullius disabitata. Uccisioni di massa ed estrazione di risorse, distruzione di sistemi di scrittura e agricoli sono alcune di queste conseguenze, così come l’interruzione della trasmissione dei saperi, intrinsecamente connessa alla disinformazione attuale su di essi. Nel caso del Messico, ad esempio, quasi tutti i manoscritti sono stati deliberatamente distrutti e i pochi sopravvissuti fra di essi si trovano quasi tutti in istituzioni europee, come il cosiddetto Codex Borgia. Risalente al XVI secolo, dal contenuto calendrico e rituale, il codice porta il nome del cardinale italiano che lo possedette fino alla sua morte, nel 1804, quando passò alla Biblioteca Vaticana a Roma. Testo centrale per la conoscenza di cultura rituale, divinazione, calendario, religione e iconografia, la sua appartenenza non è chiara: potrebbe essere stato prodotto dal popolo Tlaxcaltec di lingua Nahuatl, dal popolo Cholulteca, oppure da quello Mixtec. In relazione a questa cancellazione progressiva delle conoscenze indigene, Sandra Benites, appartenente alla cultura Guaraní Ñandeva, scrive circa l’importanza delle pratiche artistiche contemporanee nel riattivare i saperi perduti: “Fu fondamentale la registrazione fatta dai Djuruá della memoria indigena e dei modi indigeni di raccontare storie, che si sono riflessi nel grande serpente disegnato dall’artista indigeno contemporaneo Denilson Baniwa. In questi scambi è stato fondamentale avere la sensibilità per permettere all’altro di continuare ad essere altro, non abbracciandolo perché la pensa allo stesso modo. Ciò significherebbe continuare la colonizzazione. È necessario trovare un bilanciamento tra i pensieri di tutti, includendo sempre e accettando la sensazione di estraneità che può arrivare”. [3]
Se circondati da oggetti decontestualizzati dalle loro funzioni, ambiti culturali e linguistici, e allontanati dai loro contesti originari, l’esperienza di questi oggetti in un’istituzione come il Museo delle Civiltà può indurre lo spettatore a pensare che la conoscenza delle culture indigene e la loro complessità possa concludersi nello spazio circoscritto dalle vetrine museali. In questo senso è importante ricordare che ciò che noi occidentali spesso percepiamo come oggetti appartenenti ad una cosiddetta cultura materiale o immateriale, pensata storicamente entro una pratica di studi etnografici, sono in prima istanza soggetti che facevano e fanno parte di una vita sociale articolata e appartenente ad epistemologie non occidentali. Il ricercatore brasiliano Rosalvo Ivarra Ortiz (anche lui della comunità Guaraní Ñandeva) nel suo libro Cultura Material e Cosmologia Guarani em Mato Grosso do Sul (Cultura materiale e cosmologia Guaraní nel Mato Grosso del Sud) scrive: “gli oggetti sacri Guaraní in musei o mostre molto probabilmente cominciano a soffrire di nostalgia, della loro vita sociale, dai loro compagni, delle conversazioni, delle danze rituali di cui facevano parte inizialmente. Dal dialogo con i vari leader, ci rendiamo conto che certamente, sentendosi soli, gli oggetti cominciano a sentire la pressione degli sguardi estranei, di persone che non parlano la loro lingua, che non li capiscono, non sono amici, non c’è comunicazione o comprensione in questo processo”.
Alves osserva che, nel mostrare prevalentemente cesti di fibre vegetali intrecciate nella vetrina dedicata ai Guaraní, non si fa menzione di come si sia arrivati a prediligere quel materiale. Non si parla ancora nelle didascalie di come il genocidio compiuto nei confronti di questo popolo (che abita la regione brasiliana del Mato Grosso del Sud, al confine del Paraguay, ancora oggi sotto attacco del disboscamento massivo per l’industria alimentare mondiale) abbia prodotto un progressivo abbandono della ceramica, poiché difficile da trasportare quando si è forzatamente costretti a fuggire per salvarsi dai massacri nella propria stessa terra. Se guardiamo adesso ad una delle vetrine dove si tematizza la violenza dei sacrifici umani compiuti dagli Aztechi, descritti come brutali assassini, notiamo come manchi ancora nelle didascalie la spiegazione del rito del sacrificio come sostanzialmente connesso ad un contesto socio-culturale e religioso, e quindi come aspetto integrale di un modo di intendere, da parte degli Aztechi stessi, la presenza dell’essere umano in relazione agli altri elementi della propria ecologia. Perché, ad esempio, nota Alves, questi sacrifici non sono messi in relazione con le morti che proprio qui a Roma venivano spettacolarizzate nel Colosseo? Il rapporto con la morte nelle culture antiche andrebbe invece sempre contestualizzato, e non trasformato in un elemento che essenzializzi l’altro in una pratica, senza leggerla nel contesto più ampio a cui appartiene?
Un’ultima, ma non conclusiva, osservazione di Alves nel suo percorso attraverso gli allestimenti attuali del Museo delle Civiltà, è relativa all’assenza di un racconto che condivida l’importanza di storici leader e pensatori indigeni nel racconto generale che il Museo fa di queste culture. Uno tra tutti è Atahualpa (1497-1533), ultimo capo Tahuantinsuyo (l’insieme dei territori dominati dalla monarchia Inca, in lingua Quechua). Catturato dal conquistador Francisco Pizarro a seguito della battaglia di Cajamarca, l’imperatore Inca chiese di poter essere liberato in cambio di un riscatto che il suo popolo pagò in oro e altri oggetti preziosi, per un ammontare di circa 1,5 miliardi di dollari in valuta corrente (si calcola che sia stato il più grande riscatto della storia). La promessa non fu però mantenuta e, dopo l’esecuzione di Atahualpa, l’imperatore europeo Carlo V riuscì ad annettere all’impero spagnolo anche i territori di Cile e Perù mentre, in quegli stessi anni, grazie ai soldi provenienti dal riscatto, l’impero spagnolo si espandeva anche in Nord Africa, con la conquista della Tunisia.
È in questo senso che Alves esprime il bisogno di reinserire, nella nostra esperienza di visita al Museo delle Civiltà, il punto di vista delle comunità indigene dalle quali le collezioni museali provengono: ma anche il bisogno di raccordare un differente racconto del passato con l’attualità di un impegno in corso per la sopravvivenza e la salvaguardia degli ecosistemi indigeni e con il legame che queste rivendicazioni hanno con il passato coloniale.
Matteo Lucchetti (testo elaborato dai dialoghi dell’autore con Maria Thereza Alves)
[1] A.Koch, C. Brierley, M. M. Maslin, S. L. Lewis, “Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492”, in Quaternary Science Reviews, volume 207, 1 marzo 2019.
[2] B. De Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie, Marsilio, 2012.
[3] S. Benites, Algunas perspectivas hacia el arte desde una visión Guaraní, “Concreta”, numero 16, (autunno, 2020), pag. 28
This text aims to provide more information on the process led by Maria Thereza Alves as a Research Fellow at The Museum of Civilizations and offer insights on texts and sources suggested by the artist in rethinking the American Arts and Cultures Collections display.
During one of Alves’ first visits to the Museum of Civilizations, after the invitation in the spring of 2022 to join the new group of artists-researchers, she was perturbed to see that in some of the vitrines of the American Arts and Cultures Collections were still exposed Shuar shrunken heads and other human remains. On that occasion, the artist agreed with Loretta Paderni, Anthropologist in charge of the collections, to have them recovered to the climatic chambers of the museum deposits. With that gesture of respect for those remains, Alves wanted to collaborate with the Museum to stop the exhibition of bodies stolen from their original tombs and subjected to the supposed scientific neutrality of a museum showcase thousands of miles from their place of origin. The Museum officers gradually removed the human remains, and from that moment on, the artist began a double dialogue: on the one hand, with her long-term contacts from the indigenous communities in Brazil – to make them aware of the objects present at the Museum – and on the other with the Museum’s team, to rethink together new possible displays that included the requests received by the indigenous communities from whose contexts the objects in the Collections come. It originates from these visits and these exchanges the intention to report, pending the re-installments that will take place in the course of 2024, what the artist feels to disagree with the current arrangements because of bias, loaded with prejudices, or not being informed about the historical reality emerged in recent decades of studies.
Analyzing the wall texts present in the existing exhibition (realized in three phases from 2000 to 2008), we note a series of stereotypical notions that reveal how much, in the information provided to visitors, the voice of subjects whose material and immaterial culture is exhibited in the Museum is still substantially absent, thus perpetuating a story that is, in fact, an expression of a Western museographic interpretation.
At the entrance of the Collections, for example, stands the phrase “1492: Europe discovers America,” reiterating the belief that the American territories were discovered by Europeans, denying the thousands-year history of the indigenous peoples who already lived there. In this regard, in the book Jungles. As the tropical forests have shaped the world and us, Patrick Robert, archaeologist and researcher at the Max Planck Institute in Munich, writes: “More and more Indigenous activists and institutions are calling for Columbus-reverence to be replaced by a celebration of pre-colonial Indigenous societies and an acknowledgment that the actions of European ‘explorers,’ and their consequences for tropical cultures, populations, and landscapes, are by no means cause for fanfare.” Other researchers in the scientific field [1] who studied the climatic aspects of that historical period stated: “While Europe was in the early days of the Renaissance, there were empires in the Americas sustaining more than 60 million people. But the first European contact in 1492 brought diseases to the Americas which devastated the native population, and the resultant collapse of farming in the Americas was so significant that it may have even cooled the global climate”. The most recent research, Robert reminds us, attests that 90% of the indigenous populations of the tropical areas were swept away in the 150 years following 1492 due to repeated waves of diseases and organized exterminations. Already in 1552, in the text, A Short Account of the Destruction of the Indies, Bartolomé de Las Casas – a Spanish Dominican priest who participated in the colonization of Cuba – narrates: “As for the vast mainland, which is ten times larger than all Spain, even including Aragon and Portugal, containing more land than the distance between Seville and Jerusalem, or more than two thousand leagues, we are sure that our Spaniards, with their cruel and abominable acts, have devastated the land and exterminated the rational people who fully inhabited it. We can estimate very surely and truthfully that in the forty years that have passed, with the infernal actions of the Christians, there have been unjustly slain more than twelve million men, women, and children. In truth, I believe without trying to deceive myself that the number of the slain is more like fifteen million.” [2]
Also, in the first room of the walkthrough, a map shows Columbus’ and his epigones’ many discoveries and conquests. Still, there is no indication of the consequences of such actions, as if those territories were a terra nullius (nobody’s land). Mass killing and resource extraction, destruction of writing and agricultural systems are some of these consequences, as well as the interruption of the transmission of indigenous knowledges, intrinsically linked to the current misinformation about them. In the case of Mexico, for example, almost all the manuscripts have been deliberately destroyed, and the few that survived among them are nearly all in European institutions, such as the so-called Codex Borgia. The codex, dating back to the sixteenth century, with its calendric and ritual content, bears the name of the Italian cardinal who owned it until his death in 1804 when it passed to the Vatican Library in Rome. Pivotal text for the knowledge of ritual culture, divination, calendar, religion, and iconography, its original belonging is uncertain: it may have been produced by the Tlaxcaltec, people speaking the Nahuatl language, the Cholulteca people, or the Mixtec. Concerning this progressive erasure of indigenous knowledge, Sandra Benites, belonging to the Guaraní Ñandeva culture, writes about the importance of contemporary artistic practices in reactivating lost knowledges: “The recording made by the Djuruá of the indigenous memory and the indigenous ways of telling stories, reflected in the great snake designed by the contemporary indigenous artist Denilson Baniwa, was fundamental. In these exchanges, it was fundamental to have the sensitivity to allow the other to continue to be the other, not embracing them because they think the same way. This would mean continuing colonization. It is necessary to find a balance between the thoughts of all, always including and accepting the feeling of estrangement that can come from it.” [3]
If surrounded by objects decontextualized from their functions, cultural and linguistic areas, and removed from their original contexts, the experience of these objects in an institution such as the Museum of Civilizations can lead the viewer to think that the knowledge of indigenous cultures and their complexity can end in the space circumscribed by the museum display. In this sense, it is essential to remember that what Western culture often perceives as objects belonging to a so-called material or immaterial culture, historically thought within a practice of ethnographic studies, are, in the first instance, subjects that were and are part of an articulated social life and belonging to non-western epistemologies. Brazilian researcher (also Guaraní Ñandeva) Rosalvo Ivarra Ortiz writes in his book Cultura Material e Cosmologia Guarani em Mato Grosso do Sul (Guaraní Material Culture and Cosmology in South Mato Grosso): “Guaraní sacred objects in museums or exhibitions, most likely begin to suffer from nostalgia, their social life, from their companions, conversations, ritual dances of which they were part at birth. We realize from the dialogue with the various leaders that they certainly feel lonely. The objects begin to feel the pressure of foreign looks, of people who do not speak their language, who do not understand them, are not friends, and there is no communication or understanding in this process.”
Alves observes that, in showing mainly baskets of vegetable fibers woven in the showcase dedicated to Guaraní, there is no mention of how they have come to prefer that material. There is still no mention in the captions of how the genocide against this people (who inhabits the Brazilian region of South Mato Grosso, on the border of Paraguay, still under attack by massive deforestation for the world food industry) has produced a progressive abandonment of ceramics because it is difficult to transport it when you are forced to flee for your life from massacres in your own land.
Let’s now look at one of the showcases where the violence of the Aztecs’ human sacrifices, described as brutal killers, is discussed. We notice how the explanation of the rite of sacrifice is still missing in the captions. The rite is substantially connected to a socio-cultural and religious purpose, and therefore, as an integral aspect of understanding, by the Aztecs themselves, the presence of the human being in relation to the other elements of their ecology. Why, for example, notes Alves, are these sacrifices not put in comparison to the deaths that were turned into a spectacle in the Colosseum, right here in Rome? The relationship with death in ancient cultures should instead always be contextualized and not transformed into an element that essentializes the other in a practice without reading it in the broader context to which it belongs.
One last, but not final, observation of Alves in his journey through the current installations of the Museum of Civilizations is related to the absence of a story that shares the importance of historical indigenous leaders and thinkers in the general narrative that the Museum makes of these cultures. One of them is Atahualpa (1497-1533), the last Tahuantinsuyo chief (the group of territories dominated by the Inca monarchy in the Quechua language). Captured by the conquistador Francesco Pizarro following the Battle of Cajamarca, the Inca Emperor asked to be freed in exchange for a ransom that his people paid in gold and other valuables, for an amount of about 1.5 billion dollars in current currency (it is calculated that it was the highest ransom in history). However, the promise was not kept, and after the execution of Atahualpa, the European emperor Charles V managed to annex to the Spanish Empire the territories of Chile and Peru while, in those same years, thanks to the money coming from the ransom, the Spanish Empire was also expanding into North Africa, with the conquest of Tunisia.
It is in this sense that Alves expresses the need to reintroduce, in our experience of visiting the Museum of Civilizations, the point of view of the indigenous communities from which the museum collections come, but also the need to link a different story of the past with the relevance of an ongoing commitment to the survival and preservation of indigenous ecosystems and with the link that these claims have with the colonial history.
Matteo Lucchetti (text elaborated by the author’s dialogues with Maria Thereza Alves)
[1] A.Koch, C. Brierley, M. M. Maslin, S. L. Lewis, “Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492”, in Quaternary Science Reviews, volume 207, March 1, 2019.
[2] B. De Las Casas, A Short Account of the Destruction of the Indies, Penguin Books Ltd, 1992.
[3] S. Benites, Algunas perspectivas hacia el arte desde una visión Guaraní, “Concreta”, n. 16, (fall, 2020), p. 28